
Un elemento che differenzia l’essere umano dagli altri esseri viventi è la sua condizione di “essere sociale” e il bisogno costante di mettersi in relazione con il mondo che lo circonda e con le altre persone.
Potremmo immaginare le relazioni come tre livelli concentrici che hanno il loro punto di partenza nell’io, ossia nel singolo individuo. A questo si aggiungono:
- il noi – la famiglia, le amicizie e le persone con cui condividiamo maggiormente la nostra vita;
- gli altri – un insieme indefinito di persone che vivono diversamente da noi (per età, stile e luogo di vita), con cui generalmente non entriamo in relazione ma che comunque esistono.
Come abitare queste tre sfere siamo noi a deciderlo: siamo più concentrati su noi stessi? Ci interessa maggiormente sentirci parte di un gruppo definito? Preferiamo spendere la nostra vita per gli altri dimenticando a volte chi ci sta vicino o i nostri stessi bisogni?
La sfida maggiore è trovare un equilibrio, consapevoli che in ogni dimensione è possibile donarsi e arricchirsi, amare e essere amati
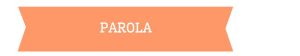
Dal Vangelo di Luca (10,25-37)
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù riprese:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ lo stesso».
La parola chiave è PERSONE
DOMANDE DI RIFLESSIONE, personale o in gruppo
- Quando sperimento il mio bisogno di relazione? Cosa mi guida nelle relazioni? Cosa penso quando dico di qualcuno che è “una bella persona”? Come avverto le inevitabili fatiche del mio entrare in relazione con gli altri? Come vedo le persone che condividono questo cammino?
- Quali sono le situazioni nelle quali avverto che ho bisogno degli altri e come mi pongo per far crescere relazioni significative nel mio cammino umano e di credente in cerca del senso delle cose (forse abbiamo già sperimentato che le cose sono importanti come “strumenti”, mentre le persone sono più sul piano delle finalità, degli obiettivi)? Cosa prevale in me: “umiltà” (sono stato chiamato, ma non ho meriti, sono uno fra tanti fratelli, mi metto a disposizione…) o “presunzione” (se Dio mi ha chiamato, significa che valgo più di altri!).
- C’è bisogno di curare la mia interiorità (ascolto, riflessione, dialogo e pazienza), più che la mia esteriorità (quanto è importante l’abito che indosso, come considero le “manifestazioni esterne” e il “seguito personale”)?

MISSIONARI DI SPERANZA IN ECUADOR
“Il missionario è chiamato a stare tra la gente, con la gente. In questo contesto difficile la speranza è di creare l’armonia delle differenze”.

Attività “Intervista allo specchio”
Obiettivo: approfondire la conoscenza dell’altro e di se stessi, mettersi nei panni dell’altro. È importante spiegare che durante l’attività non bisogna rispondere o reagire alle risposte date dallo “specchio”, ma alla fine dell’attività riflettere su come ci siamo sentiti, sull’impressione che diamo agli altri e su come e quanto profondamente ci conoscono gli altri.
Dinamica: i partecipanti del gruppo si dividono in coppie e si dispongono uno di fronte l’altro. Uno di loro sarà “lo specchio” dell’altra persona. Inizia la persona interrogando il suo “specchio” con alcune domande che lo riguardano, di conoscenza (es. come ti chiami? quanti anni hai? cosa fai nella vita? ecc.). Lo “specchio” dovrà rispondere a ciascuna domanda immaginandosi essere la persona che gli sta di fronte. Dopo alcuni minuti si invertono i ruoli.
Per riflettere
Si propone di riflettere in gruppo per un confronto e scambio reciproco: Quando, in che situazione, mi sono sentito ‘altro’, in necessità di un aiuto che non trovavo? Quando sono riuscito a ‘spogliarmi’ del mio abito mentale per dare un aiuto? Dove mi sono lasciato interpellare dalla situazione imprevista, riuscendo a modificare il mio cammino già pianificato? Mi capita di sentirmi solo tra tanti o di rendermi conto di aver ignorato l’altro accanto a me?

Musica: “Io sono l’altro” di Niccolò Fabi
Questa canzone intitolata “Io sono l’altro”, esplora il tema dell’alterità. Ci interroga su chi sia “l’altro” e su come dovremmo rapportarci a chi percepiamo come “diverso” e “strano”, spesso alimentando un senso di estraneità. Ci aiuta a riflettere sulle modalità attraverso cui guardiamo al mondo e al nostro prossimo, con particolare riguardo nei confronti di coloro che di solito ignoriamo, o rifiutiamo. Il testo risuona profondamente nel nostro mondo attuale dove respiriamo un clima di odio, divisione e intolleranza.
L’autore propone una soluzione potente a questa frammentazione: l’empatia. Attraverso un’analisi profonda e precisa, esplora i diversi aspetti della nostra anima e del mondo che ci circonda.
“Io sono l’altro” offre un modo per guardare il mondo con occhi nuovi, andando oltre la miopia e la retorica. È una proposta concreta per una cura necessaria che dobbiamo mettere in pratica oggi per affrontare le divisioni che ci circondano.
Musica: “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi
Riflette sul desiderio (e sull’incapacità) di incarnare l’idea convenzionale di “duro”: invincibile, forte, imperturbabile. Lucio Corsi costruisce un ritratto ironico e malinconico di chi vorrebbe essere un “robustone”, ma si scopre fragile e sensibile. Il brano suggerisce che la fragilità non è un limite da superare, ma una parte autentica dell’identità, e riconoscerla può essere un atto di coraggio. Tra ironia, immagini poetiche e un sound retro, Lucio Corsi racconta che la vera durezza può essere accettare se stessi – fragilità inclusa.
Quadro: “Le due Frida” di Frida Kahlo (1939)
Il dipinto Le due Frida di Frida Kahlo rappresenta il conflitto interiore e l’identità duale dell’artista. Le due figure, sedute fianco a fianco, simboleggiano i suoi due lati: la Frida legata alle radici messicane, con abito tradizionale, e quella più europea e moderna. I loro cuori, uno sanguinante e uno intatto, sono collegati da vene e un filo rosso, esprimendo la sofferenza fisica ed emotiva di Frida, legata al dolore per la fine del suo matrimonio e alla sua condizione di salute. Nonostante la divisione apparente, le due Frida sono unite, a indicare che si tratta di un’unica persona con un’anima indivisibile. Lo sfondo grigio e desolato sottolinea il senso di isolamento, tristezza e solitudine vissuto dall’artista in quel periodo.
Quadro: “Stanza a New York” di Edward Hopper (1932)
Precursore della Pop Art è tra i maggiori pittori realisti americani, Edward Hopper è soprattutto il pittore che è riuscito a dipingere la solitudine del ‘900. È conosciuto per le sue rappresentazioni di vita quotidiana urbana in ambienti domestici e luoghi pubblici, dove sembra non ci siano rumori.
La scena è spesso deserta, immersa nel silenzio; raramente vi è più di una figura umana, e quando ve ne è più di una, sembra emergere una drammatica estraneità e incomunicabilità tra i soggetti. La direzione dei loro sguardi o i loro atteggiamenti spesso “escono dal confine del quadro”, nel senso che si rivolgono a qualcosa che lo spettatore non vede. Di lui è stato detto che sapeva “dipingere il silenzio”.
Film: “Il favoloso mondo di Amelie” (2001)
Il favoloso mondo di Amélie (titolo originale: Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, 2001), diretto da Jean-Pierre Jeunet, è una delicata e surreale favola moderna ambientata nella Parigi di Montmartre.
La protagonista, Amélie Poulain, è una giovane donna introversa ma profondamente sensibile, che decide di dedicare la sua vita a rendere felici le persone che la circondano, attraverso piccoli gesti segreti e poetici. Il film segue il suo percorso tra fantasie, malinconie e incontri bizzarri, fino alla scoperta dell’amore e del coraggio di vivere per sé stessa. È un film che celebra la bellezza delle piccole cose, la gentilezza e il potere dell’immaginazione. Nonostante la leggerezza apparente, tocca anche temi più profondi come la solitudine, l’infanzia negata e la ricerca di senso. “Il favoloso mondo di Amélie” ci insegna a vivere con più attenzione, più coraggio e più cuore, riscoprendo la bellezza dell’essere umani – con tutte le nostre stranezze e imperfezioni.
“Il favoloso mondo di Amélie” offre diversi spunti di riflessione e insegnamenti, sia sul piano emotivo che esistenziale. Ecco alcuni dei messaggi principali che si possono trarre dal film:
- La felicità nasce dalle piccole cose: Amélie trova gioia nei dettagli: infilare le mani in un sacco di legumi, far rimbalzare i sassi sull’acqua, osservare le persone senza farsi notare. Il film ci insegna a rallentare e a riscoprire il valore delle piccole esperienze quotidiane, spesso trascurate.
- Fare del bene agli altri può arricchire anche noi stessi: Nel cercare di migliorare la vita delle persone attorno a lei, Amélie scopre un senso di scopo e connessione. Tuttavia, il film mostra anche che aiutare gli altri non può sostituire il coraggio di affrontare la propria vita.
- Osare è necessario per essere felici: Amélie è brava a prendersi cura degli altri, ma ha paura di esporsi. Il film ci insegna che non basta sognare o immaginare, a un certo punto bisogna fare un salto nel vuoto, rischiare e mettersi in gioco, soprattutto in amore.
- L’immaginazione può essere una forza potente, ma anche una gabbia: Amélie vive in un mondo tutto suo, fatto di fantasia e sicurezza. Ma questo isolamento la rende anche sola. Il film mostra l’equilibrio tra immaginazione e realtà, tra sogno e azione.
- Tutti portano con sé fragilità nascoste: Ogni personaggio del film – dal vecchio pittore al verduraio burbero – ha una storia, una paura o una mancanza. Amélie ci invita a guardare gli altri con più empatia e curiosità, perché dietro ogni persona c’è qualcosa che non vediamo subito.
Film: “Quasi amici” (2011)
Quasi Amici” è un film del 2011 che racconta l’improbabile amicizia tra un aristocratico tetraplegico e un giovane di periferia appena uscito di prigione.
Trama
Il film segue la storia di Philippe Pozzo di Borgo, un ricco aristocratico che, dopo un incidente di parapendio, diventa tetraplegico. In cerca di un badante, Philippe incontra Driss Bassari, un giovane senegalese che si presenta al colloquio solo per ottenere una firma necessaria a continuare a ricevere sussidi statali. Sorprendentemente, Philippe decide di assumerlo nonostante il suo atteggiamento disinteressato e poco professionale.
Con il passare del tempo, tra i due si sviluppa un legame profondo e sincero. Driss, con il suo approccio diretto e la sua personalità vivace, porta una ventata di freschezza nella vita di Philippe, che si sente intrappolato nella sua condizione. Insieme, affrontano le sfide quotidiane e scoprono nuove esperienze, creando un’amicizia che supera le barriere sociali e culturali.
Temi Principali
Il film esplora temi come l’amicizia, la disabilità, e la capacità di trovare gioia e significato anche nelle situazioni più difficili. La relazione tra Philippe e Driss dimostra come le differenze sociali possano essere superate attraverso la comprensione e l’accettazione reciproca.
Finale
Nel finale, Driss decide di cercare un nuovo lavoro per contribuire alla sua famiglia, mentre Philippe, dopo aver provato altri badanti, si rende conto che nessuno può sostituire il legame speciale che aveva con Driss. La storia si conclude con un messaggio di speranza e di crescita personale per entrambi i personaggi.

Se mi apro ad una dimensione missionaria, come mi sto preparando ad incontrare ‘il mondo altro’ che mi si apre davanti ogni giorno, attraverso le migrazioni dei popoli, la convivenza civile sempre più faticosa, i viaggi internazionali? Li vedo come un vero scambio tra persone e tra Chiese?